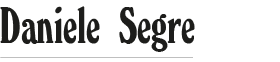Umberto Rossi/ Rockerilla
Il cinema italiano attraversa una fase di grande travaglio, ma segnata anche dall'emergere di energie nuove. Come ha dimostrato il cartellone dell'ultima Mostra di Venezia sono molti i giovani registi che si stanno affacciando alla ribalta. Anche se la cosa può sembrare sin troppo ovvia, bisogna segnalare subito la grande differenza di stili e di esiti: si passa dalla ricerca estetica coraggiosa e di taglio quasi documentaristico avviata da Daniele Segre in “Manila Paloma Blanca” alla riflessione politico-esistenziale ad alto contenuto stilistico a cui si dedica Mario Martone con “Morte di un matematico napoletano”, dalla rappresentazione realistico estetizzante che tanto affascina Aurelio Grimaldi, autore de “La discesa di Aclà a Floristella”, alla prospezione sociologico sentimentale a cui si rivolge Carlo Mazzacurati ne “Un'altra vita”, dalla vocazione alla farsa di costume mostrata da Fulvio Wetzl in “Quattro figli unici” alla diligente trasposizione del testo teatrale di successo in cui ci s'imbatte in “Volevamo essere gli U2” di Andrea Barzini. Pur tenendo conto dei valori specifici messi in campo da ciascuno di questi film, è possibile varare una prima suddivisione separando gli autori che si mettono dietro la macchina da presa per fare cinema da quelli che lavorano pensando prevalentemente alla destinazione televisiva dei materiali che stanno girando. E' una diversa impostazione culturale e stilistica che risalta sin da un primo esame delle opere, esemplificata da tagli d'inquadratura, dominanza di primi e primissimi piani, mancanza d'immagini in campo lungo o lunghissimo, censure estetiche, politiche o sessuali. Si intenda bene: quasi nessun film oggi può far quadrare il proprio bilancio senza far ricorso ai proventi derivanti dai diritti d'antenna o ai ricavi legati alle vendite delle videocassette. Tuttavia, una cosa è considerare questi apporti come uno fra gli addendi del capitolo entrate, un'altra è guardare ad essi come la sola giustificazione dell'opera. Prendiamo, ad esempio, “La discesa di Aclà a Floristella” e confrontiamolo con “Volevamo essere gli U2”. Sono molte le peculiarità espressive che separano questi due film, ma la prima è riconducibile alla diversa attenzione che i due registi rivolgono ai valori cinematografici formali del discorso che stanno proponendo: tanto Aurelio Grimaldi si cura di disegnare le inquadrature con abbondanza di dettagli e profondità di campo, altrettanto Andrea Barzini appare sciatto, poco preciso, del tutto indifferente ai particolari e agli sfondi. Analogo discorso potrebbe farsi per il modo, diametralmente opposto, con cui le due opere utilizzano le suggestioni del paesaggio e per la cura posta nella direzione degli attori. Certo queste sono solo alcune fra le molte differenze che è possibile cogliere fra il film d'esordio dell'autore del romanzo da cui Marco Risi ha tratto “Meri per sempre”, e l'opera del responsabile della trascrizione cinematografica della fortunata commedia di Umberto Marino. Altri punti di divergenza, tutti a favore del film di Aurelio Grimaldi, sono la partecipazione e lo spirito di denuncia civile che segna il racconto dei triboli patiti dal piccolo minatore, la cura nella ricostruzione scenografica, l'attenzione alla struttura drammaturgica, il dolore e la rabbia che cadenzano l'impasto su cui si regge il film sul “caruso” siciliano. Tutti questi dati positivi sono in parte deteriorati dall'estetismo quasi esasperato che guida la mano del regista inducendolo a disegnare gli interni della miniera quasi fossero raffigurazioni di un Inferno dantesco utilizzare con troppa insistenza musiche barocche.
“La discesa di Aclà a Floristella” ha trovato posto nella sezione competitiva della Mostra assieme ad altri due film italiani: “Fratelli e sorelle” di Pupi Avati e “Morte di un matematico napoletano” di Mario Martone. Il primo segna una tappa poco fortunata del percorso espressivo del regista di “Una gita scolastica” (1983) e “Ragazzi e ragazze” (1989).
Questa sua recente fatica segue la vena americana inaugurata da “Brix” (1990) e presenta difetti del tutto analoghi a quelli del film precedente. Anche in questo caso, infatti, Pupi Avati non riesce a restituirci alcun sapore d'America e le immagini che ci propone appaiono forzate e inautentiche. E' una fragilità di base che finisce coll'indebolire storia e personaggi dando alle vicende di questa famiglia scompaginata, ai turbamenti postadolescenziali del giovane Francesco e alle sue ansie il gusto sgradevole di una costruzione architettata a tavolino e del tutto priva di autentica, sofferta tensione espressiva. Diverso il caso dell'esordiente Mario Martone, già affermato uomo di teatro, animatore del gruppo “Falso Movimento” e della compagnia “Teatri Uniti”. Gran parte del fascino di “Morte di un matematico napoletano” nasce dall'abilità della regia nel trasformare un sofferto ritratto individuale in un caso politicamente emblematico, senza perdere spessore analitico, rigore psicologico o drammaticità narrativa. Siamo nel 1959, tre anni dopo il trauma causato nella coscienza di migliaia di intellettuali e militanti comunisti dalla violenta repressione della rivolta ungherese da parte dell'Armata Rossa. L'otto maggio di quell'anno il professor Renato Caccioppoli, uno dei luminari della matematica moderna, si suicidò sparandosi un colpo alla nuca nella sua casa napoletana. Il fatto destò scalpore sia per la notorietà scientifica del morto, sia per il suo passato politico di perseguitato antifascista, militante comunista e, per giunta, nipote dell'anarchico russo Bakunin. Mario Martone ricostruisce gli ultimi giorni di vita di questo personaggio, ne coglie sbandamenti e allucinazioni, lo pedina nel girovagare spesso disperato e senza meta, ci parla dell'alcolismo che lo divorava, ne tratteggia stravaganze ed eccentricità come quella di indossare un impermeabile sopra pantaloni e maglia per la pelle anche a primavera avanzata, racconta i suoi incontri con allievi, travestiti, studiosi, popolani. Quello che emerge è il quadro di una disperazione esistenziale le cui radici affondano in una brutale delusione politica. Un contributo determinante alla riuscita del film viene da Carlo Cecchi che interpreta con ricchezza di sfumature il travaglio di un intellettuale lucido sino all'autodistruzione. Le immagini che scorrono sotto i nostri occhi ci parlano di fallimento dei sogni, tracollo delle illusioni, inaridirsi delle speranze, naufragio di un'intera generazione. In quelle calde giornate di maggio, nei vicoli e nelle strade napoletane che il matematico percorre con passo spinto dall'ossessione, si disegna il bilancio di un'epoca che si sta chiudendo e l'annuncio di una nuova era, volgare e opportunista, che avanza con passo trionfale. Un film forte e complesso, ricco di suggestioni e significati che vanno ben oltre la rappresentazione, pur variegata e sensibile, della crisi di un individuo particolarmente sensibile e fragile.
Pazzia e disadattamento sono anche i temi a cui si rivolge Daniele Segre con “Manila, Paloma Bianca”, un film stimato da molti come il migliore fra i titoli apparsi nella Vetrina del Cinema Italiano. Alessandrino trapiantato a Torino, questo giovane regista segue da tempo un filone narrativo che ha al centro i problemi dell'emarginazione, del disadattamento, della diversità. Un percorso le cui tappe più significative sono alcuni documentari narrativi come “Il potere deve essere bianconero” (1978) sui supporter della Juventus, “Testadura” (1988) sull'amaro destino dei giovani ex-contestatori e “Vite di ballatoio” (1984) sulla vita grama di un gruppo di travestiti. Al centro di questo suo ultimo film c'è un attore un tempo famoso, oggi ridotto a far vita randagia al limite della mendicità. Dopo vari soggiorni in ospedale psichiatrico e in centri per la disintossicazione degli alcolisti, incontra un momento di pace nella calda e generosa ospitalità di Sara, una donna ancor giovane che subisce il fascino della sua ricca personalità. Purtroppo anche questa sosta si rivelerà breve e illusoria, la follia in agguato leverà la testa proprio quando tutto sembrava essere rientrato nei binari della “normalità” e all'ex-attore non rimarrà che riprendere la strada delle mense per i poveri e le camerette d'albergo pagate dall'assistenza pubblica. Il film è stilisticamente robusto e trae forza da un linguaggio articolato sull'alternanza fra colore e bianco e nero, la sgranatura della fotografia, l'impasto con materiali elettronici. Il procedere del racconto appare spezzettato e frammentato, mentre i movimenti della macchina da presa tendono ad accentuare la sensazione che si stia assistendo alla proiezione di un documentario e non di un film di finzione. Quest'insieme di dati stilistici confluisce nel disegno di un quadro tinteggiato di disadattamento e disagio, un panorama che va ben oltre il referto psicanalitico per approdare alla messa in discussione dell'aurea piattezza del vivere “normale”. Sempre in tema di marginalità da segnalare anche “Un'altra vita”, opera quarta di Carlo Mazzacurati in cui si racconta l'incontro impossibile fra un tranquillo dentista romano e una profuga russa. La donna compare, scompare, ritorna solleticando la curiosità, anche erotica, del professionista che ne segue le tracce immergendosi in un sottobosco affaristico e delinquenziale popolato di torvi borgatari arricchitisi col traffico di droga e usura. Il film è punteggiato da intuizioni psicologiche ficcanti e presenta sequenze che confermano il valore di una giovane regista il cui lavoro si colloca fra le punte alte del nostro cinema.